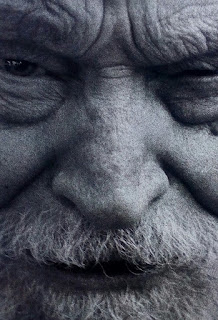- Cronologia-
1915
26 APRILE
L’Italia aderisce al patto di Londra con l’Intesa.
3 MAGGIO
L’Italia denuncia la Triplice Alleanza.
23 MAGGIO
L’Italia presenta la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria.
24 MAGGIO
L’Italia comincia le ostilità con l’Austria-Ungheria. Prima veloce avanzata fino al confine militare austriaco.
23 GIUGNO – 7 LUGLIO
Prima battaglia dell’Isonzo, senza risultati rilevanti.
18 LUGLIO - 4 AGOSTO
Seconda battaglia dell’Isonzo, senza risultati rilevanti.
18 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE
Terza battaglia dell’Isonzo, con lo scopo di aiutare i serbi. L’offensiva italiana viene respinta.
10 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE
Quarta battaglia dell’Isonzo, con scarsi risultati.
1916
11 – 19 MARZO
Quinta battaglia dell’Isonzo, decisa dai francesi per distogliere truppe tedesche dal fronte di Verdun. L’offensiva italiana viene respinta.
15 – 24 MAGGIO
L’esercito austriaco al comando del maresciallo Franz Conrad, scatena un’offensiva nel Trentino.
29 MAGGIO
Gli austriaci occupano Asiago.
4 – 10 GIUGNO
Battaglia sull'altopiano di Asiago.
12 – 16 GIUGNO
L’estremo tentativo austriaco contro il Novegno e il Lemerle fallisce.
16 GIUGNO – 24 LUGLIO
Controffensiva italiana che ottiene risultati parziali.
6 AGOSTO – 16 SETTEMBRE
Sesta battaglia dell’Isonzo. Avanzata italiana e conquista di Gorizia (9 AGOSTO).
27 AGOSTO
L’Italia dichiara guerra alla Germania.
14 – 16 SETTEMBRE
Settima battaglia dell’Isonzo. Offensiva italiana respinta.
10 – 12 OTTOBRE
Ottava battaglia dell’Isonzo. Offensiva italiana respinta.
1 – 4 NOVEMBRE
Nona battaglia dell’Isonzo. Limitati successi italiani.
1917
12 – 28 MAGGIO
Decima battaglia dell’Isonzo. Limitati successi italiani.
4 GIUGNO
Controffensiva austriaca sul Carso, che vanifica in gran parte le recenti conquiste italiane.
10-25 GIUGNO
Offensiva della VI armata italiana sull'altopiano di Asiago (battaglia dell’Ortigara), risoltasi con un sanguinoso fallimento.
17 AGOSTO – 15 SETTEMBRE
Undicesima battaglia dell’Isonzo. Limitati successi tattici italiani (Conquista dell’altopiano della Bainsizza e del Monte Santo).
4 SETTEMBRE
Attacco austriaco sul Carso.
24 OTTOBRE
I tedeschi e gli austriaci rompono il fronte italiano davanti a Tolmino e a Plezzo. Gli italiani devono ripiegare dietro il Tagliamento e quindi dietro il Piave.
8 NOVEMBRE
Armando Diaz sostituisce Luigi Cadorna come capo di stato maggiore del Regio Esercito.
10-26 NOVEMBRE
Battaglia d’arresto italiana sull'altopiano di Asiago, sul Grappa e sul Piave.
1918
15-23 GIUGNO
Offensiva austriaca da Asiago alle foci del Piave; respinta dalle truppe italiane.
24 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE
Offensiva che si conclude con la vittoria di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti.
da "Maledetti Balcani" - Paolo Rumiz racconta la Grande Guerra
contributo fotografico da #SPUNTIDISTORIA della Prof.ssa Lucia Tracanzan (novembre 2018), approfondimento sulla Prima Guerra Mondiale nel nostro territorio